Furono i Romani che per primi disciplinarono la circolazione in quelle, che possiamo definire, le prime vere autostrade dell’epoca; vere e proprie arterie stradali, preziose per le esigenze commerciali, militari e di comunicazione, le consolari.


Il grande Giulio Cesare, un anno prima della morte, promulgò quella legge che possiamo definire la madrina dell’attuale Codice della Strada: la LEX IULIA MUNICIPALIS.
Fu una vera rivoluzione che andò a disciplinare la circolazionae di quei veicoli che, ancora oggi, il codice della strada disciplina con attenzione: i carri (oggi veicoli a trazione animale).
Il tutto scaturì dalle esigenze di regolamentare la circola zionae di quei veicoli che, ancora oggi, il codice della strada disciplina con attenzione: i carri (oggi veicoli a trazione animale).
Il tutto scaturì dalle esigenze di regolamentare la circolazione, evidentemente rischiosa e caotica, dei carri all’interno di Roma.
Sembra che gli incidenti fossero abbastanza frequenti ed allora il centro di Roma tenne a battesimo il primo abbozzo di codice della strada o meglio di zona a traffico limitato (Z.T.L.).
Con anticipo di qualche millennio, quindi, i Romani anticiparono quelle che sono norme attualissime regolamentando l’accesso e la conduzione dei carri all’interno della città.

Ai mezzi pesanti fu vietato di transitare dall’alba sino al pomeriggio.
Da tale divieto erano esclusi: carri per la raccolta della nettezza urbana, per il trasporto di laterizi, per la costruzione di edifici pubblici, religiosi, ecc.
In Italia la prima normativa riguardante i veicoli a motore (automobili) venne stabilita dal Regio Decreto n° 416 del 28 luglio 1901, o “Regolamento per la circolazione delle automobili sulle strade ordinarie”.
Questo prevedeva una licenza costituita da un libretto sul quale dovevano essere annotate le eventuali contravvenzioni.
Il cavallo era il veicolo per eccellenza e, proprio grazie a questo nobile animale, l’uomo cominciò a spostarsi più celermente,In Italia la prima normativa riguardante i veicoli a motore (automobili) venne stabilita dal Regio Decreto n° 416 del 28 luglio 1901, o “Regolamento per la circolazione delle automobili sulle strade ordinarie”.
Questo prevedeva una licenza costituita da un libretto sul quale dovevano essere annotate le eventuali contravvenzioni. Il cavallo era il veicolo per eccellenza e, proprio grazie a questo nobile animale, l’uomo cominciò a spostarsi più celermente, riuscendo così a conquistare nuove terre ma anche a comunicare con altri popoli e a potenziare gli eserciti.
Per l’uomo ormai il cavallo era divenuto un vero e proprio “veicolo”, indispensabile ed insostituibile, del quale non poteva fare più a meno.
Ma proprio come accade oggi con altri tipi di cavalli – quelli a motore – anche in epoca remota se ne abusava, tenendo velocità non correlate alle situazioni o comportamenti che potevano creare potenziale pericolo: nacque perciò la necessità di porre delle regole per evitare e contrastare tutto questo. Proprio perché la circolazione diveniva sempre più pericolosa e fuori controllo nel 1865 fu emanata una legge che stabiliva alcune regole sulla velocità e disciplinava anche il comportamento dei conducenti di veicoli a trazione animale: i tempi si sono evoluti ma i problemi a distanza di qualche secolo sono più o meno i medesimi.
Se intorno nella metà del 1800 nasce il primo codice della strada, proprio in quegli anni, grazie all’avvento delle prime macchine a vapore, per il cavallo sarebbe iniziato un lento ma inesorabile declino.
Eppure se i veicoli a motore sostituirono il cavallo, il “Codice della Strada” a partire dal primo del 1901 sino all’attuale del 1992, aggiornamenti compresi, hanno sempre contemplato la circolazione degli animali e dei veicoli a trazione animale….

I veicoli a trazione animale sono stati per l’uomo, prima dell’avvento dei veicoli a motore (1840), un elemento essenziale per lo sviluppo delle sue attività e per la conquista e la scoperta di nuove terre.
Oggi il “Codice della Strada” continua a regolamentarne sia la circolazione nonché i requisiti per l’utilizzo in luoghi pubblici (immatricolazione ai fini della circolazione su aree e strade pubbliche).
La circolazione con “attacchi” quindi non deve essere trattata con leggerezza e può comportare serie responsabilità soprattutto
in materia civilistica, ma anche
penale.
I veicoli a trazione animale sono classificati come segue:
- veicoli destinati principalmente al trasporto di persone (targa rossa);
- veicoli destinati principalmente al trasporto di cose (targa verde);
- carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole (targa azzurra)
- i veicoli a trazione animale muniti di pattini denominati slitte.
I veicoli a trazione animale devono essere dotati di dispositivi di frenatura, di segnalazione visiva nonché le caratteristiche dei cerchioni delle ruote. Il rispetto di tali requisiti permetterà di ottenere ciò che sarà indispensabile per poter circolare su aree e strade pubbliche: la targa.
Proprio la targa è l’elemento essenziale ed indiscutibilmente necessario per poter circolare in luoghi pubblici con il nostro attacco (nessuno escluso).
Cosa dobbiamo fare per ottenere il rilascio della targa?
La targa la deve rilasciare il Comune di residenza del proprietario.
Chi certifica il possesso dei requisiti?
Sicuramente la ditta costruttrice del veicolo. Può accadere però che, trattandosi di veicolo d’epoca o di veicolo la cui costruzione è sconosciuta, non si abbia nessun documento.
Come si può ovviare a questo problema?
Vi sono periti abilitati che rilasciano tali certificazioni.
In occasione di raduni e sfilate storiche in luoghi pubblici, le carrozze attaccate a cavalli potranno partecipare anche se prive di targa.
Gli organizzatori dovranno ottenere la preventiva autorizzazione delle ente/i proprietario/i della strada/e.
La sfilata dovrà essere dotata di scorta tecnica che anticipa e chiude, salvo che non venga addirittura disposta la sospensione della circolazione degli altri veicoli per il tempo necessario. Gli enti proprietari della strada chiederanno agli organizzatori specifica polizza assicurativa. E’ sempre opportuno contattare preventivamente le Amministrazioni pubbliche che potrebbero essere interessate dal percorso.
E’ necessaria una patente per condurre animali da soma e da sella o i veicoli a trazione animale?
La risposta è NO. Il codice della strada, mai modificato per quanto concerne la conduzione degli animali da soma e da sella nonché per i veicoli a trazione animale, stabilisce esclusivamente il rispetto di due requisiti: essere idoneo per requisiti fisici e psichici e avere compiuto anni quattordici per guidare.

IL SERVIZIO DI PIAZZA…
UNA VERA E PROPRIA ATTIVITA’ COMMERCIALE!!!
l servizio di piazza non è altro che un servizio pubblico di trasporto persone a pagamento, effettuato in questo caso con veicoli a trazione animale; un vero e proprio equi-taxi.
E come tale deve essere trattato a livello amministrativo tant’è che elemento indispensabile per l’esercizio di tale attività è l’ottenimento della specifica licenza. E proprio per la delicatezza del servizio che si andrà a svolgere, il legislatore ha stabilito prescrizioni e limitazioni assai più severe come:
- l’idoneità certificata sia dei conducenti che degli animali;
- l’aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il 65°;
- la revisione quinquennale. Il Sindaco può, in qualsiasi momento lo ritenga necessario, disporre la revisione.
Cosa si deve fare per ottenere tale licenza? Innanzitutto bisogna presentare domanda al Sindaco del Comune ove si voglia esercitare l’attività.
Quanto in precedenza trattato è solo una parte delle norme che riguardano il nostro settore contemplate nel Codice della Strada.
Il mio studio ha lo scopo di contribuire a formare e rendere edotto chi conduce animali o veicoli a trazione animale, mettendolo in condizione di circolare sulle strade pubbliche nel rispetto di determinati doveri ma anche consapevoli di eventuali diritti.
Testo e foto di Claudio Barsuglia ex Com.te P.M. Camaiore Membro della Commissione Sviluppo del Dipartimento Equitazione di Campagna F.I.S.E. e archivio GIA.
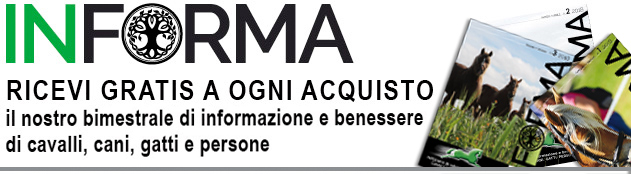
L’articolo completo è pubblicato sulla rivista INFORMA n. 1/2025

























































